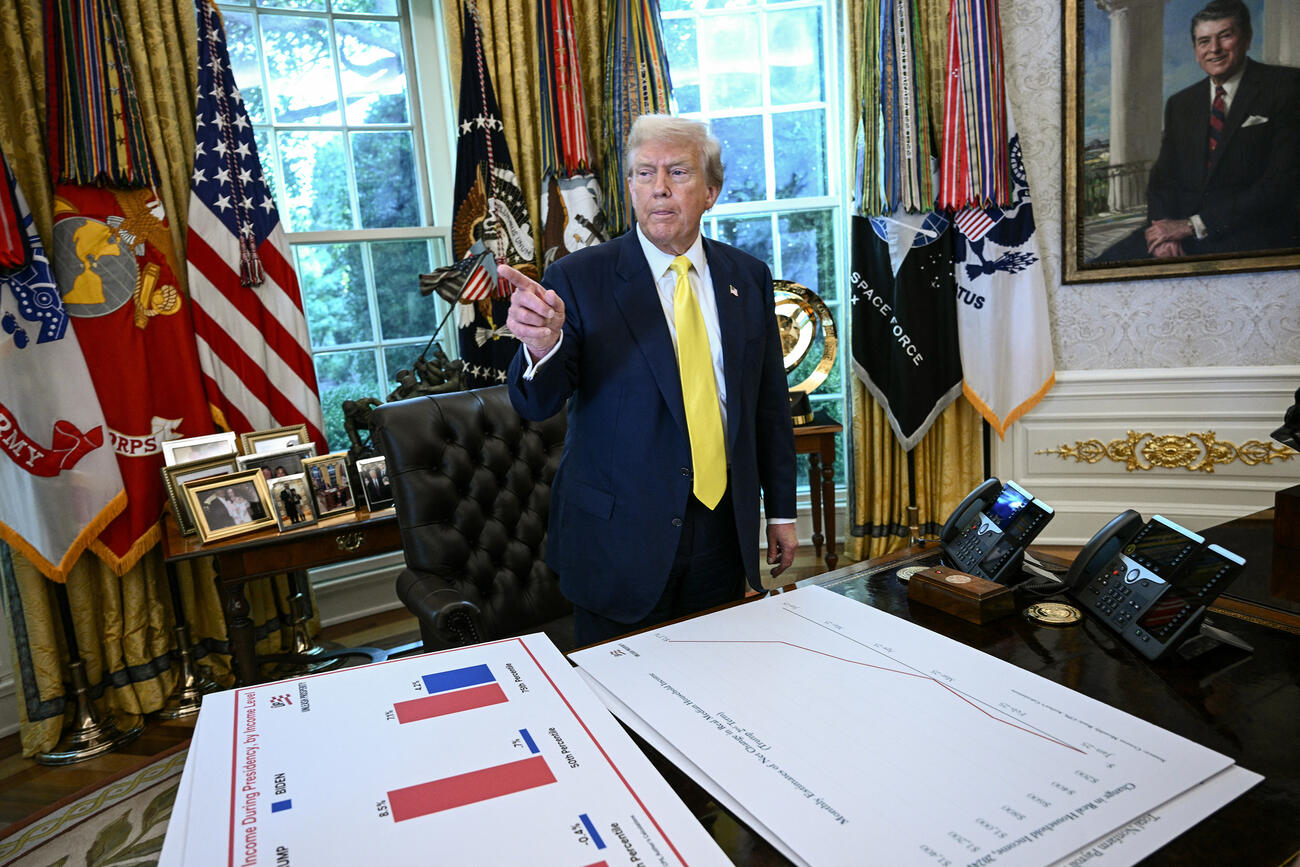di Giorgio La Malfa
Il Mattino, 22 luglio 2016
Mi auguro sia così. Penso però che il governo italiano sia comunque troppo lento nell’affrontare questi problemi e forse troppo diviso al suo interno.
Giorgio La Malfa
Ha detto Mario Draghi, nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla riunione mensile del Consiglio della Banca centrale europea, che la crescita nell’area dell’euro è fiacca e che vi è il rischio che ancor più si infiacchisca nei prossimi mesi. Quanto all’inflazione che ricordiamolo dovrebbe stare «al disotto, ma vicino a12% annuo», essa si aggira intorno allo 0%, cioè non dà segni di andare nella direzione dove dovrebbe andare e dove andrebbe se l’economia europea fosse in ripresa. La Bce ha detto Draghi continua il suo programma di acquisti di titoli di stato che ha finora evitato che l’Europa ripiombi nella deflazione ed ha anche attenuato i riflessi finanziari negativi del referendum inglese.
Ma da sola la Bce non basta. Il problema è che quando dalla diagnosi si passa a ciò che bisognerebbe fare, Draghi diventa in parte reticente e in parte contraddittorio. In realtà, che cosa servirebbe è assolutamente chiaro. E lo è da molti anni. Se un’economia non tira anche quando la politica monetaria è così espansiva da portare a zero i tassi di interesse, evidentemente ci si trova di fronte a una insufficienza della domanda complessiva di consumi e di investimenti. E se è così, allora c’è una sola cosa da fare: per fare ripartire l’economia serve una spinta della domanda aggregata e questa spinta non può che venire dal bilancio pubblico.
Lo stimolo può prendere la forma di forti e consistenti riduzioni del prelievo fiscale oppure quella di un deciso aumento delle spese per infrastrutture ed altri investimenti pubblici. O può consistere di un misto fra le due. Ma se questo non avviene e se le circostanze esterne: l’andamento dell’economia mondiale, le aspettative degli imprenditori, le preoccupazioni dei consumatori sono tutte marcate in senso sfavorevole, l’economia può al massimo restare più o meno piatta se non avvitarsi al ribasso. Dunque per uscire dalla crisi serve uno stimolo che può provenire solo dalla finanza pubblica. Il problema è che l’Europa non può fare una politica di bilancio, neppure quando l’evidenza è così palese ed indiscutibile.
Non può farla perché non c’è un governo europeo che p o ssa decidere di prelevare più o meno tasse o di spendere più o meno risorse e di farlo indebitandosi, ma soprattutto non può farla perché il trattato di Maastricht da cui sono nati l’euro e la Bce prescrive politiche di bilancio che vanno esattamente nella direzione opposta a quello che servirebbe in questo momento. Impongono di perseguire i bilanci in pareggio anche quando il farlo aggrava condizione già di per sé difficili. Draghi per esempio ha detto ieri che quest’anno nel loro insieme i bilanci europei sono espansivi ma che già dall’anno prossimo questo elemento di stimolo fiscale verrà meno. E non aggiunge che si tratta di una vera e propria follia. Come si è scritto molte volte su questo giornale, talvolta Draghi sembra consapevole di questo problema, tanto da invocare anche oggi politiche fiscali growth friendly, cioè favorevoli alla crescita.
E poiché quando c’è disoccupazione e fino a che c’è disoccupazione, più deficit si fa meglio è, le politiche che Draghi invoca dovrebbero essere di questo genere. Ma Draghi non può spingersi a dirlo in modo chiaro. Anzi è costretto a insistere su politiche che vanno esattamente nella direzione opposta. Sono necessarie ha detto politiche strutturali che puntano all’aumento della produttività del lavoro. Le politiche strutturali in materia di lavoro sono il mantra dei conservatori ed hanno la caratteristica di essere assolutamente controproducenti nelle fasi in cui la domanda aggregata è bassa. Perché? Perché il modo più incisivo di aumentare la produttività del lavoro è ridurre l’occupazio ne licenziare I lavoratori per chiamare le cose con il loro nome.
Sono le politiche che ha fatto l’Italia con il jobs act, attenuandone gli effetti a prezzo di enormi esborsi di denaro pubblico a favore delle imprese e che sta tentando la Francia con la sua legge sul lavoro. Queste politiche sono assolutamente sconsigliabili quando il problema è la domanda. Il loro affetto principale è di ridurla ulteriormente, come si è visto nell’esperienza di tutti questi anni. Dunque Draghi agisce bene sul piano monetario, ma è costretto a predicare cose contraddittorie fra loro. E comunque, a chi le predica, visto che non c’è un governo europeo?
Egli si rivolge indirettamente ai governi nazionali. Ma la situazione di questi ultimi è più o meno la seguente. Vi sono alcuni Paesi che avrebbero spazio per fare politiche fiscali espansive perché hanno pochi debiti. La Germania è il principale fra questi. E se la Germania facesse una politica espansiva, trascinerebbe nella ripresa molta parte dell’area dell’euro, a cominciare dall’Italia. Ma la Germania non ha alcuna voglia di fare queste politiche di cui non condivide l’essenza e soprattutto non ha alcun bisogno di esse perché la sua forza lavoro è pienamente occupata. Altri Paesi, come l’Italia o la Spagna o il Portogallo hanno un gravissimo problema di disoccupazione, specialmente fra i giovani e quindi avrebbero bisogno di una spinta del bilancio pubblico, ma hanno alti deficit o alti debiti pubblici e quindi temono le conseguenze di muoversi e subiscono le minacce della Commissione europea, delle società di rating e di tutti i benpensanti.
Ecco perché l’area dell’euro non va da nessuna parte: ed è trascinata dalla corrente che in questo momento non è favorevole alla ripresa. Se vi fosse una robusta ripresa economica, questo attenuerebbe la depressione che deriva dal quadro internazionale dell’immigrazione, del terrorismo ed anche della repressione delle libertà in paesi assai a noi vicini. Se manca un’azione pubblica a sostegno della ripresa, tutti questi fattori depressivi sono liberi di manifestarsi e di cumularsi fra loro.
Tutto questo è o dovrebbe essere chiaro agli economisti e soprattutto ai governi europei che dovrebbero cercare insieme di imprimere una svolta alla politica economica dell’area dell’euro. O se questo non fosse realizzabile, i governi più coraggiosi dovrebbero prendersi la responsabilità di agire da soli. Prima che lo scontento degli europei travolga nelle urne tutto quello che si è cercato di costruire negli anni del dopoguerra.