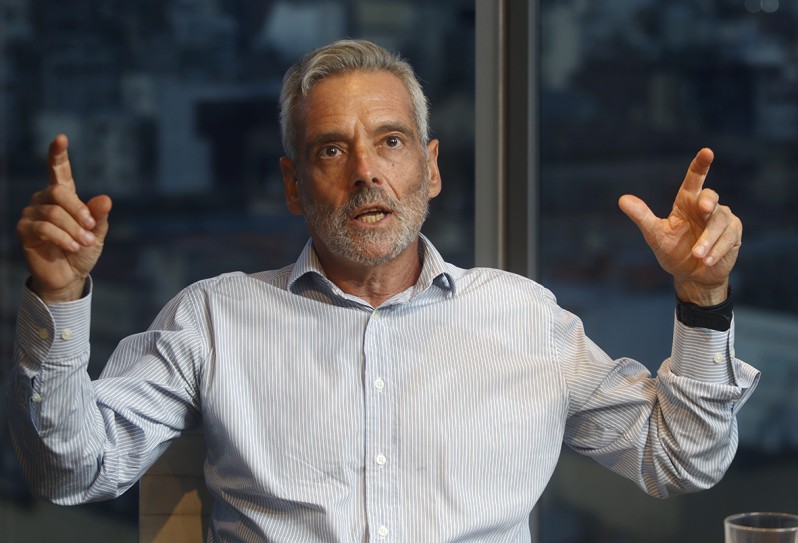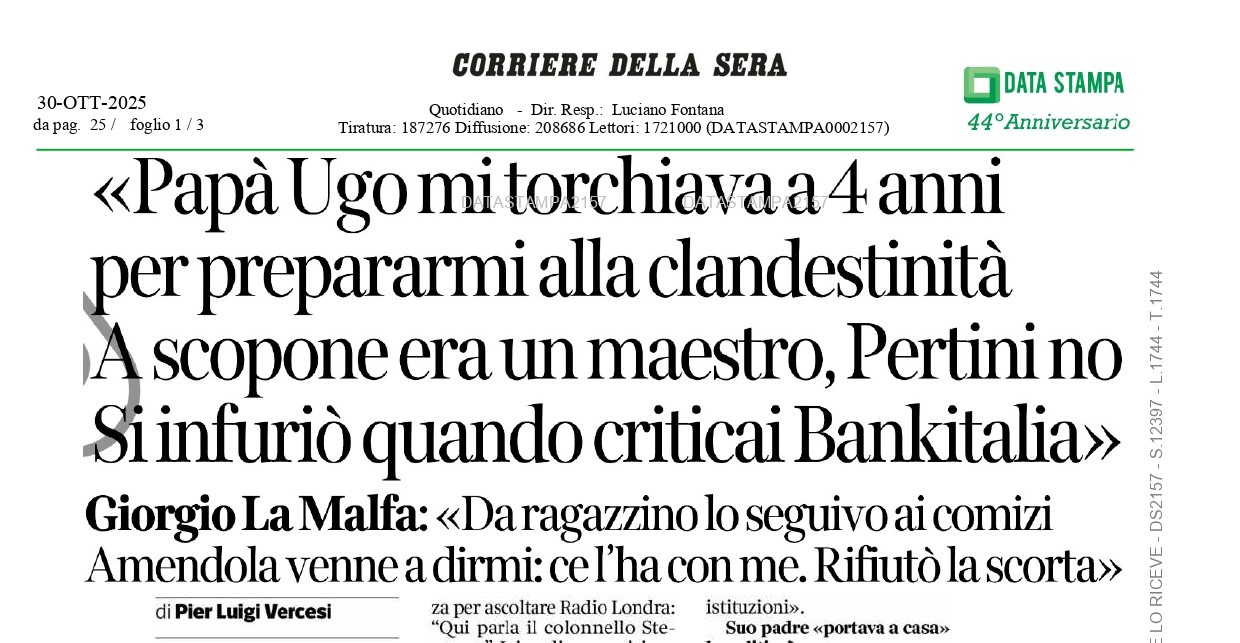Che cosa significa che la BCE decide di tener fermi i tassi? Che essa non ravvisa né le condizioni per allargare, né per stringere, diversamente dalla FED. Ma le condizioni di contesto, tra le due sponde dell’Atlantico, sono diverse. E anche se l’inflazione è negli Stati Uniti più elevata che nell’area dell’euro, lì pare aver pesato la dinamica dell’occupazione, oggi meno favorevole di qualche mesa fa. Ma la FED ha un mandato duale (crescita e stabilità). Quello della BCE è centrato sulla sola stabilità dei prezzi. E qui, nell’area euro, la disinflazione si è realizzata. L’inflazione, che nel 2022 aveva raggiunto il picco del 10%, è oggi intorno al 2%. Certo, l’incertezza permane, per la guerra dei dazi e per le guerre guerreggiate, e infatti Francoforte non assume impegni per il futuro, se non quello di continuare a decidere incontro dopo di incontro e “sulla base dei dati”.
Insomma, è finito l’attivismo che, in un verso prima e nell’altro poi, ha caratterizzato gli ultimi dieci anni, prima con l’espansione monetaria (per far fronte ai rischi della deflazione nel post-Grande recessione), poi con la restrizione (per far fronte a quelli dell’inflazione nel post-Covid e Ucraina). Il mare pare (pare) calmo: e la BCE spegne i motori e decide di andare col vento.
Ma la crescita, che pure secondo la BCE tutto sommato regge, resta pur sempre modesta, intorno all’1 per cento. E il messaggio implicito è che il compito di propiziarla e realizzarla spetta ai governi e alle imprese, con investimenti pubblici e con investimenti privati. Hic sunt leones.
Perché, se è vero che nel breve termine la crescita europea dipende anche, in certa misura, dalla capacità per la Germania di fuoriuscire definitivamente dalle secche della recessione e per la Francia dall’endemica instabilità politica, dall’altra è inutile negare che quel poco di crescita che c’è stata negli ultimi anni è dipesa anche, e nel caso dell’Italia soprattutto, dai piani di ripresa legati al Next Generation EU (il PNRR), che termineranno nel 2026. E dopo? A suo tempo si era detto che sarebbe stato opportuno pensare a una qualche forma di sua riproposizione, magari aggiungendo una “s”: Next Generations, come compito e impegno permanente per il futuro. Ma quel “momento hamiltoniano” (il debito comune, la prospettiva federale …) sembra finito, e non vorremmo che si tornasse a un più o meno larvato “tempo jeffersoniano”, secondo il quale, come è noto, il “governo che governa meglio è il governo che governa meno”. L’Europa ha bisogno di decidere e di organizzarsi, insomma ha bisogno di Politica: specie in questa nuova “età del ferro”, come si va dicendo, in cui decisioni vitali per il suo futuro vengono assunte fuori dai suoi confini.
Giovanni Farese è Professore ordinario di Storia economica nell’Università Europea di Roma. Insegna Storia dell’economia nella LUISS Guido Carli. È Managing Editor di The Journal of European Economic History e Marshall Memorial Fellow del German Marshall Fund of the United States.